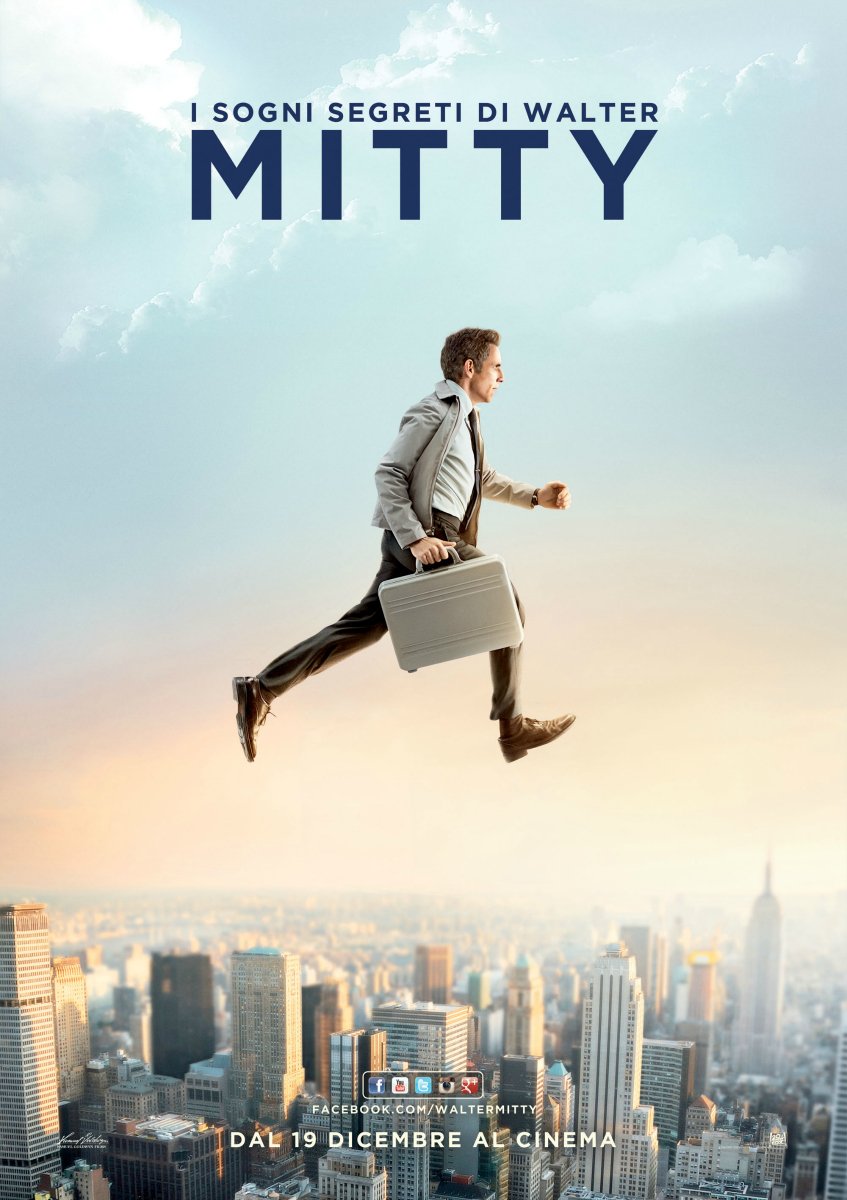Di solito si concludono le interviste chiedendo dei nuovi progetti in corso d'opera, stavolta inizio chiedendoti a che punto è il tuo progetto su Pompei?
Non ne parlerei, non per scaramanzia ma perché vorrei parlare di cose concrete, più concrete possibile, non di intenzioni. Tra la gestazione di
Giro di lune e questo film sono passati 19 anni, non voglio far passare di nuovo troppo tempo...
Per amor vostro
era un progetto precedente a quello di Pompei?
No.
Pompei è prima di
Giro di lune,
Per amor vostro è stato ideato e ha vinto un premio per la sceneggiatura nel 2008 ed è stato realizzato nel 2014.
Come è avvenuto il coinvolgimento del cast? Come sei arrivato a Valeria Golino?
Valeria l'ho corteggiata quasi due anni e mezzo fa. Non mi rispose, quindi pensai ad un'altra attrice di cui mi ero e sono tuttora innamorato, ma con l'andar del tempo mi sono reso conto che avevo bisogno di un'attrice un pochino più giovane per poter fare il nido, la covata; era difficile che una donna di sessanta anni si potesse ribellare. Mentre Valeria con i suoi 48 anni era giusta con l'età per poter decidere di cambiare vita.
Quindi ho sentito Valeria Golino un anno e mezzo fa, ha letto la sceneggiatura che la prima volta non aveva letto. Ha detto "ci sto, non so cosa succederà, ma nel progetto ci sto". Con lei poi abbiamo costruito tutto via via.
Hai raccontato che la sceneggiatura di Per amor vostro
era di ferro, anche se si ha l'impressione che il film abbia una musicalità di ritmo che a volte fa pensare a spazi di improvvisazione, quasi da free jazz.
Ci sono solo tre scene che abbiamo spostato in blocco interno, ma anche le altre scene spostate erano già costruite in quella maniera lì. La composizione della musica è stato un lavoro di molti mesi, quasi un anno con i musicisti, per cercare il tema, per cercare questa musicalità, per cercare la possibilità di montare musicalmente la storia. Non potevo girare le scene senza avere la musica, anche il semplice tema.
Per cui la costruzione del film può sembrare libero, ma è soltanto una concentrazione di ritmo interno alla storia. Le scene erano scritte in quella maniera.
Anche passare dal dettaglio al totale era già scritto in sceneggiatura. Noi abbiamo girato come era scritto. Siamo stati molto diligenti. Alle volte poi io chiudo la sceneggiatura e giro quello che penso, io sono il notaio di me stesso. Ma se succede qualche imprevisto: l'attore non è in grado di farlo, le comparse non arrivano, nell'incidente si modella la storia all'interno delle possibilità che avevo, ma questi momenti hanno sempre tenuto fede alla storia. Ogni giorno c'erano tre scene da girare e queste scene erano già scritte, mandate a memoria da tutti.
Quindi la musica è già presente prima ancora del montaggio?
Sì la musica era stata già composta con strumenti campionati e l'abbiamo usata durante il montaggio. Poi alla fine del montaggio una volta deciso il minutaggio esatto, (togliere 5 secondi in una musica è complesso), si è aspettato il montaggio definitivo, abbiamo fatto il timing esatto e abbiamo inserito le musiche.
Questo dà un grande ritmo al film.
La cosa importante è che gli Epsilon Indi sono stati molto intelligenti. È un gruppo che si allarga e si stringe nelle varie occasioni, noi lavoriamo con loro da molti anni. Hanno avuto l'intelligenza di seguire o anche di abbandonarsi alle mie paturnie per raggiungere quella qualità. Sono riusciti, pur essendo romani, a scrivere ed eseguire in napoletano, ad immergersi in una dimensione che non gli apparteneva. Si sono fidati. Gli sono grato. Hanno capito che bisognava spiritualizzare queste emozioni. Anche nella musica rielaborata del Quartetto Cetra o quella su testo di Händel, la combinazione sonoro-scena è molto forte e vincolante.
Ho notato che il suono è quasi onnipresente, persino nella scena d'amore sul ciglio del territorio vulcanico, (scena che mi ha ricordato il finale di Notti di Cabiria
), c'è un suono inquietante, un rumore quasi infernale.
Lì c'è stato un grande lavoro di montaggio del suono, abbiamo usato 56 piste per fare quel suono. Una volta montato il film aveva una sua immagine anche sonora. Finito il montaggio della scena sono iniziate ben otto settimane di suono. Abbiamo dato corpo a questa qualità, per renderlo più essenziale ed inerente alla storia.
Il gruppo del suono era di cinque persone.
In quella scena d'amore di cui parlavi ho cercato un suono che potesse evocare qualcosa pur non essendo naturalistico. Il lavoro e il costo del film è anche potersi permettere di stare al mixer per tot settimane.
A me sembra che attraverso il tuo curriculum in qualche modo hai unito due elementi che rendono più prezioso questo tipo di film, ovvero l'elemento artigianale del cinema d'avanguardia che si fa quasi da soli, penso alle prime avanguardie (Man Ray, etc) e dall'altro lato il lavoro di documentazione, di cinema del reale girato in mezzo mondo che forse toglie il rischio di scientificità un po' fredda che hanno certi film d'avanguardia che sembrano fatti in una dimensione un po' chiusa in se stessa.
Non sempre è facile tenere insieme questi due mondi, non sempre lo si riesce a far capire bene anche ai propri collaboratori. A volte la cultura va avanti con la concatenazione e con le formule. La fatica è cercare di mantenere il rigore, di mantenere un livello di linguaggio alto. Volevo mantenere in
Per amor vostro quelle aperture che non erano solo un fatto estetico, ma di dinamica della storia.
In altri paesi sono più avanti di noi perché sperimentano di più; da noi la pigrizia dei produttori, e non solo la loro, frena il lavoro sul linguaggio. Lars Von Trier o Lynch sono i detentori della sperimentazione.
Oltre alle citazioni felliniane ho trovato infatti anche qualche accento lynchiano.
Sono citazioni inconsapevoli, poi è evidente che se tu spettatore hai scoperto il cinema con Fellini, vedi degli elementi felliniani nei film che vedi, o se lo hai scoperto con Dziga Vertov o con Kazan hai quello come schema culturale. Non mi sono detto: "faccio citazioni di Fellini o di Visconti", ho preso da queste memorie quello che mi interessava, mi interessava di raccontare una sensazione. E loro mi hanno dato la libertà, la possibilità di poter raccontare così una storia. Essere sicuro di potermi agganciare, di essere libero. Non è un film di citazioni, ho solo citato Eduardo De Filippo perché mi era necessario, così era nata l'dea sull'ignavia e sul mercato nero ancora presente a Napoli negli anni cinquanta e sessanta.
Rispetto alle citazioni viste nel film da parte degli spettatori mi dispiacciono solo se sono argomentate male, altrimenti non c'è niente di male.
Il grande lavoro è stato quello di creare dei nessi tra i vari blocchi narrativi, nessi che non sono lineari. Gli sceneggiatori mi spingevano a spostare alcuni momenti perché secondo loro sarei arrivato più velocemente, ma io dicevo che non volevo arrivarci velocemente ma progressivamente, con una dinamica imprevedibile. Non volevo fare
Un posto al sole. Quando giravamo a Napoli la gente ci chiedeva se eravamo di
Un posto al sole o de
La squadra. Tutti avevano quei riferimenti, questo crea un meccanismo perverso.
Un regista indipendente la difficoltà che ha è quella di tener sempre ferma la barra e far capire che non sprechi denaro e che non sei gestibile. Non volevamo essere originali in maniera fine a se stessa, ma volevamo raccontare una dimensione mentale, un meccanismo, e l'altro è fare affiorare la memoria degli spettatori. Le citazioni come diceva Borges sono solo dei casellari per incasellarci ma non è il modo giusto per avvicinarsi alla storia.
La storia parte da questa donna che fa i gobbi per le fiction televisive. Li ho visti in uso quando come scenografo lavoravo in tv. Li usava anche Chiambretti, che, per le sue stupidaggini così calcolate e col ritmo di lavoro così disumano, aveva bisogno di quei cartelli.
Così ho provato a mettere in scena tutto questo, provare a raccontare il rovescio, con la finta soggettiva.
Abbiamo girato tutto in sequenza, in piano sequenza e con le scene concatenate, non c'era la possibilità di agganciarsi a nulla e gli attori lo sapevano che dovevano rimanere sempre in tensione. È stato uno sforzo per tutti. È stato un terno che abbiamo vinto.
Seguivo l'attore e non la macchina.
A volte chi lavora nel cinema ha la tendenza di seguire delle strade precostituite, c'è una routine che invece io scardinavo, dopo tre quattro giorni di lotte per farmi capire, si sono abbandonati completamente al mio modo di costruire la storia.
Come costruisci un soggetto e una sceneggiatura?
La prima scena che ho scritto è la scena sul terrazzo, tra la madre e la figlia, che inizialmente era molto più lunga. Poi ho scritto tutte le scene delle liti in famiglia. Successivamente le scene della soap opera che erano molte di più e molto più intrecciate.
La costruzione della sceneggiatura si è evoluta, sentivo la mancanza della sorella, del fratello e di volta in volta discutevamo di cosa ci fosse bisogno per la storia. e di volta in volta abbiamo costruito delle sotto storie, dei personaggi che ruotavano intorno ad Anna. Ad esempio inizialmente le figure della truccatrice e del direttore di scena erano più sviluppate. Lei si confidava su come ingannare i figli per poter fuggire con l'amante. C'erano più livelli di narrazione
Poi il lavoro più grande è stato con Isa e con Lina Sarti, che è mia suocera. Con lei avevo scritto Pompei. È una signora di 82 anni. È laureata in lettere antiche, ha avuto la curiosità di leggere le mie storie. Abbiamo sperimentato su Pompei. Lei è un ottima lettrice, è colta, conosce e sa tradurre bene dal latino ed è anche una spettatrice di
Un posto al sole. E io avevo bisogno di un avvocato della storia. Poi per un po' si è assentata, quindi lavoravamo io e Isa a Roma. Poi via mail o via skype comunicavamo con lei che è a Rovigo.
Immagino che sia molto difficile per un artista uomo descrivere la storia di una donna, vedere attraverso uno sguardo che non gli appartiene. Come mai questa scelta?
Forse inconsapevolmente mi capita di comunicare con la sfera femminile molto più spesso che con quella maschile e poi c'è il fatto che a me piace, per dirla scherzosamente, essere un uomo e non un caporale.
Va bene che il maschio si occupi del suo mondo e faccia il maschio ma mi sorprendono e mi piacciono di più quei film che come
Veronika Voss di Fassbinder riescono a regalarci una visione insospettata che può essere colta diversamente.
C'è un rischio più alto. Certo io ho avuto l'aiuto di due sceneggiatrici donne, ma posso dire che se c'era qualcosa che come maschio non mi piaceva non l'ho accettata.
Credo che sia una deficienza che vada colmata; è strano pensare che a degli attori uomini il raccontare una storia di donna li faccia sentire portatori d'acqua e non portatori di intelligenza e di umanità. Verificare questo da parte di grossi attori del nostro cinema è un po' triste, pensavo che nel 2015 la bravura fosse frutto anche della loro intelligenza, invece hanno dimostrato la loro miseria.
Non fare il ruolo di Michele perché non è il protagonista e perché ha otto scene, non mi sembra una scelta intelligente, è un film corale non posso cambiare più di tanto, ho anche provato a spostare qualcosa in sceneggiatura, ma se è un film corale tale doveva rimanere. Evidentemente alcuni preferiscono l'apparire all'essere.
Mentre sono felice di aver incontrato una attrice come Valeria che pur essendo una diva, vuole essere e non apparire.
[...]
Non voglio fare sociologia o antropologia però credo che avere l'occasione di raccontare diversamente può farci abituare a pensare diversamente le cose e su questioni pensate diversamente si possono sedimentare altri pensieri e nuovi modi di vedere il mondo.
Nel tuo film c'è una dimensione di stratificazione che non è solo linguistica, ma c'è anche nei vari livelli della città, la Napoli di sopra, la Napoli sotterranea delle catacombe o la Cripta di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco. Tu dici non sono un antropologo, ma hai una curiosità antropologica.
Io non sono bravo a teorizzare, sono bravo ad individuare le contraddizioni, i poli estremi che possono essere sintomatici di qualcosa. L'antropologo sa decodificare, un film può mettere accanto due scene e poi è lo spettatore che crea i nessi.
La bellezza di Napoli, e l'ho usata come scenografia, è che è essa stessa una contraddizione vivente.
Ad esempio il rito delle anime di quella cripta è stato vietato da più di quarant'anni, ma ancora vedi dei lumini e dei messaggi. E l'idea che ci si affidi ai resti di uno sconosciuto, mai identificato è un segno di speranza e di empatia. A me come essere umano dà fiducia che ci possa essere ancora empatia, non conoscersi e sentirsi uniti tra gli ultimi. Ma dall'altro capisci che non è un sistema, sono piccoli momenti isolati di fantasia, di "follia", di evasione che tranquillizza ma che se fosse più diffusa questa empatia non ci sarebbero queste grandi contraddizioni.
L'aspetto negativo di Napoli è che c'è il gusto a fare il furbo, mi auguro che questo gusto si perda, risolve il problema della contingenza ma che non fa evolvere la situazione, gli altri si sentono presi in giro.
La truffa del mattone nei mercati di Napoli è famosissima, Nanni Loy ci ha fatto un film.
Quali sono state le collaborazioni che ti hanno dato maggiori soddisfazioni?
Un momento veramente importante è stato l'insegnamento che mi ha offerto la collaborazione con Gianni Amelio nei due film che ho potuto fare con lui (
Il ladro di bambini e
Lamerica, un anno dopo l'altro). Gianni è sempre attento all'ambiente, elabora la sua storia sulle caratteristiche dell'ambiente, sulla suggestione, sulla qualità del colore che mette in scena. È uno che racconta anche con l'ambiente, con la messa in scena. Io sono stato felice di essere stato scelto da lui.
Ho dei momenti felici con i miei musicisti, con gli Epsilon Indi.
Poi c'è stato un bell'incontro con Vittorio De Seta che stava preparando il film
Lettere dal Sahara e che aiutavo a cercare risorse finanziarie per girarlo. Mi aveva conosciuto per
Giro di lune e aveva capito che avevo uno spirito indipendente e che non delegavo ad altri. Non è che sposasse la mia linea poetica però ha riconosciuto la mia intelligenza e questo mi ha fatto piacere.
Ho anche conosciuto autori che lavorano in maniera diversa dalla mia, facendo un cinema più di parole che di immagini. Poi ho fatto degli spettacoli teatrali da Beckett (nei primi anni ottanta) e da autori di avanguardia contemporanea trovando una grande complicità con una mia amica regista.
Sul set de Il ladro di bambini
hai anche girato un documentario su Amelio, una sorta di backstage, Ioannis Amelii, Anima Vagula, Blandula
.
Quello potevo farlo perché c'era una tale complicità tra me e il maestro che acconsentiva che sul set ci fosse una telecamera accesa perché sapeva che mi serviva per essere "il suo occhio". Spesso rivedeva i filmati e faceva le sue scelte per le scenografie. Per cui accettava che vi fosse sul set la mia macchina da presa, cosa che su un set è molto difficile che avvenga. Se hai visto il film avrai notato che spesso io mettevo la macchina e poi alla fine coincideva con il suo punto macchina, e questo è coinciso in maniera sorprendente. Poi in effetti il maestro mi ha sempre detto: "non è importante dove metti la macchina da presa, puoi far fare questa scelta alla sarta, non sta lì il problema della regia". Io ho imparato tante cose del lavoro. Lui stava facendo due film che credo rimangano nella storia del cinema italiano: Il ladro di bambini e Lamerica.
Il documentario si conclude con una scena in cui tu fai sfilare tutta la troupe nella casa del carabiniere a Roma e quel finale mi ha molto emozionato perché si vede uscire di scena anche mio cugino Ubaldo Panunzi, attrezzista e trovarobe su quel set, che purtroppo è uscito troppo presto di scena anche dalla vita.